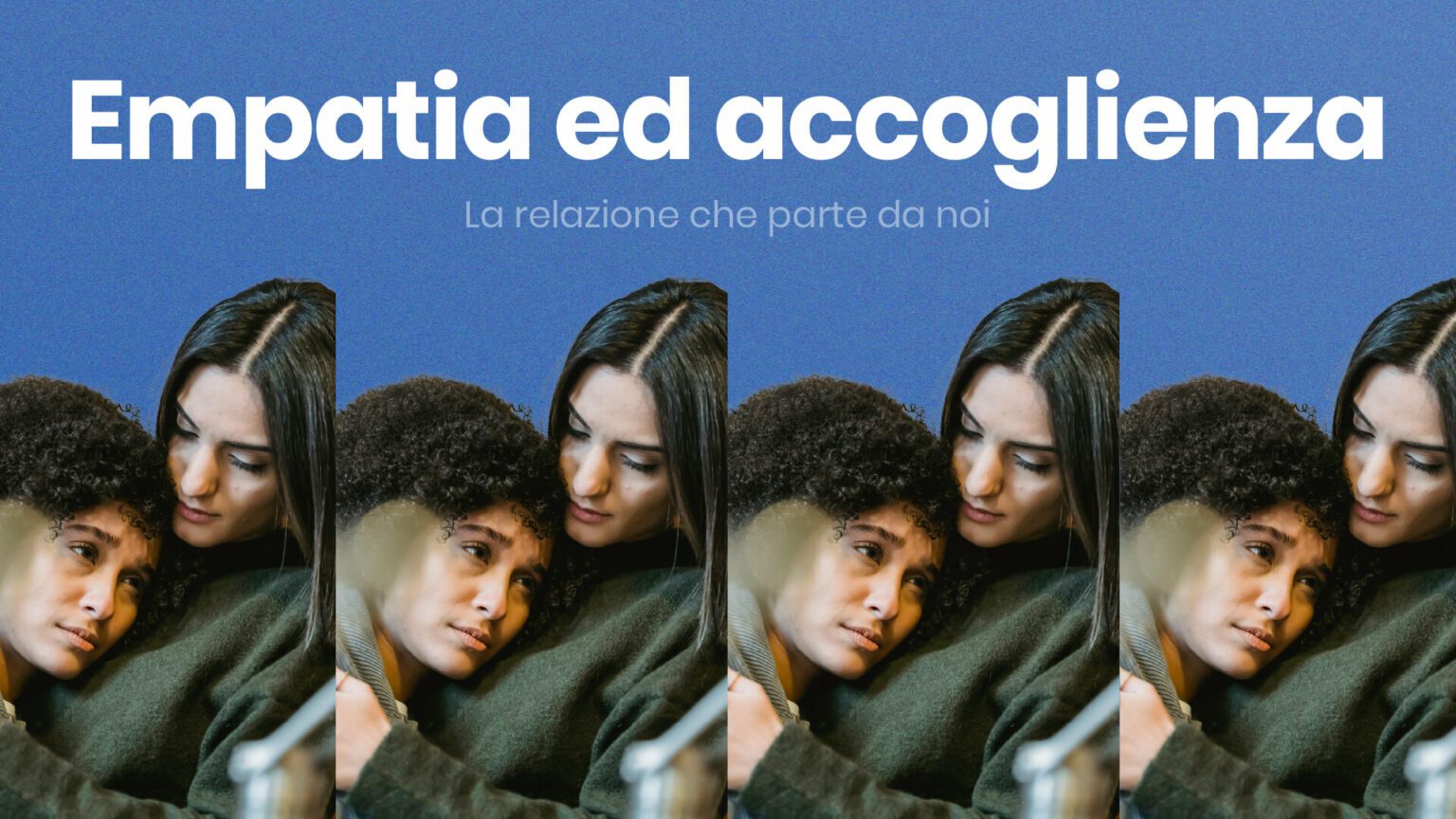Significato e storia
Il termine empatia deriva dal greco, en-pathos “sentire dentro”, e consiste nel riconoscere le emozioni degli altri come se fossero proprie, calandosi nella realtà altrui per comprenderne punti di vista, pensieri, sentimenti, emozioni. È l’abilità di vedere il mondo come lo vedono gli altri, essere non giudicanti, comprendere i sentimenti altrui mantenendoli però distinti dai propri (Morelli e Poli, 2020). Non ciò che pensiamo…ma ciò che sentiamo!
Grazie a essa si può non solo afferrare il senso di ciò che asserisce l’interlocutore, ma cogliere anche il significato più recondito psico-emotivo.

Se desideri ascoltare l’intera intervista vai sul nostro canale YouTube: “nel salotto di Antsy”
Il concetto di empatia ci accompagna in diverse epoche storiche:
- Nell’antica Grecia per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l’autore – cantautore (aedo) al suo pubblico. In filosofia è stato introdotto a fine Ottocento nell’ambito della riflessione estetica, per definire la capacità della fantasia umana di cogliere il valore simbolico della natura.
- Agli inizi del Novecento, Lipps introduce la dimensione dell’empatia in psicologia, parlando di partecipazione profonda all’esperienza di un altro essere, introducendo così il tema dell’alterità, che verrà poi ripreso dalla scuola fenomenologica. Per Lipps l’osservazione dei movimenti altrui suscita in noi lo stesso stato d’animo che è alla base del movimento osservato, tuttavia questo stato non viene percepito come una propria esperienza, ma viene proiettato sull’altro e legato al suo movimento (non ci si perde nell’altro); si tratta di empatia come partecipazione o imitazione interiore.
- A livello neurobiologico, la comprensione della mente e dei vissuti dell’altro è sostenuta da una particolare classe di neuroni: il gruppo di Rizzolatti e Gallese (1992) ha infatti formulato la teoria dei neuroni specchio, secondo cui l’empatia nasce da un processo di simulazione incarnata, un meccanismo di natura essenzialmente motoria, che PRECEDE l’elaborazione cognitiva.
- Nel 2008 Hoffman propone un modello a tre componenti: affettiva, cognitiva, motivazionale. Secondo Hoffman l’empatia si manifesta fin dai primi giorni di vita: nelle primissime manifestazioni empatiche è la dimensione affettiva ad avere il ruolo di maggior rilevanza, procedendo nello sviluppo, la componente cognitiva acquisirà un’importanza crescente e si compenetrerà sempre di più con quella affettiva, permettendo lo sviluppo di forme più evolute di empatia. Un terzo fattore, la componente motivazionale, dipende dal fatto che condividere l’emozione dell’altro, soccorrendolo, fa provare a chi aiuta uno stato di benessere; viceversa, la scelta di non confortare l’altro porterebbe con sé un senso di colpa. L’acquisizione di questa funzione, dato l’alto livello di complessità dei meccanismi cognitivi implicati, ha un’evoluzione graduale, che trova, in buona parte delle persone, pieno compimento intorno ai 13 anni.
Molto si è scritto ed ulteriormente approfondito e negli ultimi anni al concetto di empatia si associa sempre di più quello di intelligenza emotiva cioè “la capacità di monitorare le proprie e le altrui emozioni, di differenziarle e di usare tali informazioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni” (Salovey e Mayer, 1990).
L’abilità di riconoscimento e comprensione delle emozioni sia in se stessi che negli altri e l’utilizzo di tale consapevolezza nella gestione e nel miglioramento del proprio comportamento e delle relazioni con gli altri (Morgese, 2018) esplicita sin da subito la centralità di questa competenza in relazione ad ogni ambito della vita.
L’autore che resta più influente in tema di intelligenza emotiva è Goleman che, alla base dell’intelligenza emotiva, individua due tipi di competenze, quella personale, ovvero come controlliamo noi stessi e quella sociale, ossia il modo in cui gestiamo le relazioni con l’Altro (Goleman, 1995). Quando non si sviluppa l’intelligenza emotiva si corre il rischio di diventare analfabeti emotivi (o analfabeti emozionali), ovvero si diventa incapaci di riconoscere e controllare le proprie emozioni, e si ha difficoltà a riconoscere anche le emozioni altrui. Riuscire a decidere in maniera flessibile quando, come e quanto attivare il sentimento empatico, a seconda delle situazioni e della persona o del contesto sociale in cui interagiamo, ci renderebbe in grado di evitare di ricadere nei due estremi di assenza o eccesso di empatia. Considerata non solo come una forma di conoscenza, ma anche come un processo cognitivo, l’empatia è dunque un’abilità che può essere praticata, allenata, e in cui si può diventare esperti.
L’empatia è una delle principali porte d’accesso agli stati d’animo e in generale al mondo dell’altro e risulta pertanto fondamentale per ogni relazione interpersonale.
Mancanza di empatia e psicopatologia
I disturbi di personalità del cluster B, caratterizzati da tratti di drammaticità e impulsività, comportano una alterazione delle relazioni interpersonali e una disregolazione emotiva, che può almeno in parte essere ricondotta ad un deficit a livello empatico. Nello specifico:
Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP) Gli elementi distintivi del disturbo narcisistico di personalità riguardano fondamentalmente tre temi: idea grandiosa di sè, costante bisogno di ammirazione e mancanza di empatia. Facendo riferimento a quest’ultima caratteristica, si può affermare che spesso i pazienti affetti da narcisismo non siano in grado di mettersi nei panni degli altri e di riconoscere che anche loro abbiano desideri, sentimenti e necessità. Da questo deriva la convinzione dei narcisisti che le proprie esigenze vengano prima di tutto e che il loro modo di vedere le cose sia l’unico universalmente giusto;
Disturbo Istrionico di Personalità (DIP) La persona affetta da disturbo istrionico di personalità è caratterizzata da un’emotività eccessiva e da ricerca di attenzione. In particolare il paziente manifesta disagio nei contesti in cui non è al centro dell’attenzione, un comportamento seduttivo e/o provocante, emotività esageratamente inappropriata, instabile e superficiale, uso dell’aspetto fisico come mezzo per attirare l’attenzione su di sè, eloquio di tipo impressionistico, alta suggestionabilità, tendenza a considerare le relazioni più intime di quanto non siano realmente. Sicuramente uno degli aspetti su cui si sviluppa il trattamento di questi pazienti è quello di aumentare le abilità sociali, incluso il senso di empatia, evitando atteggiamenti troppo seducenti o provocanti.
Disturbo Borderline di Personalità (DBP) Il disturbo borderline di personalità è una condizione caratterizzata da pattern a lungo termine di instabilità emotiva, interpersonale e comportamentale. Le serie difficoltà manifestate nelle relazioni interpersonali potrebbero essere dovute, almeno in parte, a difficoltà nella sfera empatica e dei processi della teoria della mente. Una nuova ricerca dell’Università della Georgia indica che questo potrebbe collegarsi ad una scarsa attività cerebrale in regioni importanti per l’empatia nei pazienti con tale disturbo. Altri recenti studi (Guttman and Laporte, 2000; Lynch et al., 2006), invece, evidenziano che nel disturbo borderline vi sarebbe una risonanza esagerata e iperaffettiva con lo stato mentale dell’altro, determinata da una dissociazione tra le componenti affettive e cognitive dell’empatia.
Disturbo Antisociale di Personalità (DAP) La persona affetta da disturbo antisociale di personalità è caratterizzata principalmente da inosservanza e violazione dei diritti degli altri, che si manifestano in un soggetto maggiorenne, almeno dall’età di 15 anni. L’infanzia è di solito costellata da piccoli furti, menzogne e scontri; l’adolescenza da episodi di abuso di sostanze e, raggiunta l’età adulta, vi è manifesta incapacità ad assumersi responsabilità, conservare un’occupazione e mantenere una relazione affettiva in maniera stabile. Il modo di rapportarsi agli altri è drasticamente connotato dalla superficialità e dalla mancanza di rispetto per i sentimenti e le preoccupazioni di chi li circonda, in genere si possono definire poco empatici e poco sensibili ai sentimenti o ai diritti altrui.

Indicazioni bibliografiche
- Giusti, E., e Azzi, L. (2013). Neuroscienze per la psicoterapia. La clinica dell’integrazione trasformativa (Vol. 23), Sovera Edizioni.
- Hoffman, M.L. (2008). Empatia e sviluppo morale. Il Mulino
- Gallese, V., Migone, P., e Eagle, M. N. (2006). La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi. Psicoterapia e scienze umane.
- Choi-Kain L. W. & Gunderson J. G.. (2008). Mentalization: Ontogeny, Assessment, and Application in the Treatment of Borderline Personality Disorder, American Journal of Psychiatry, 165, 1127–1135.
Cerca altri contenuti nel nostro Blog
Per conoscere gli specialisti e tutte le attività di Antsy
Contattaci, ti chiamiamo per dirti chi siamo e, se vorrai, fare insieme il primo passo.